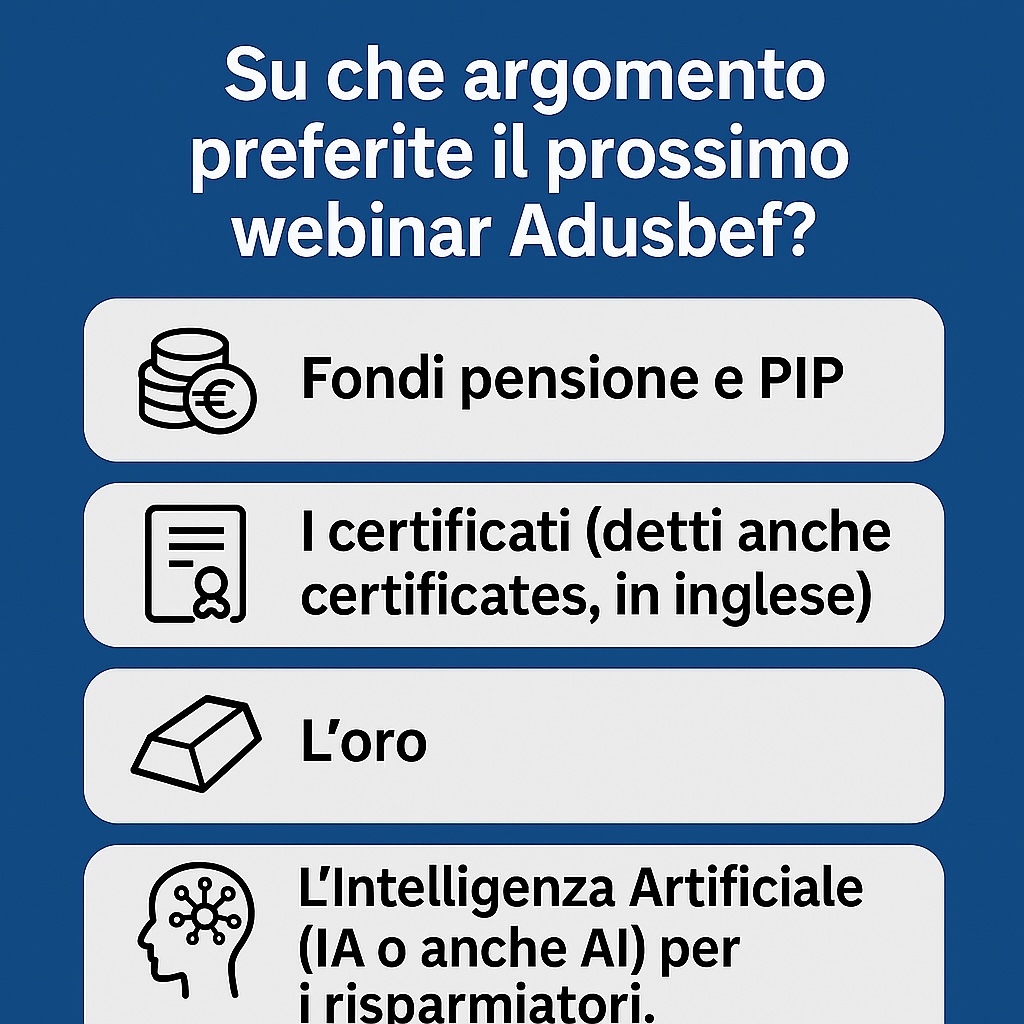NESSUNO SVILUPPO CON LA RIDUZIONE DEL DEBITO Dott. Francesco Strocchia (strocchiafra@libero.it)
NESSUNO SVILUPPO CON LA RIDUZIONE DEL DEBITO
Dott. Francesco Strocchia (strocchiafra@libero.it)
Sommario: 1) Introduzione 2) Effetti dell’introduzione dell’Euro 3) Le spinte deflazionistiche conseguenti agli accordi di Maastricht 4) Il sovvertimento delle teorie economiche consolidate 5) Gli effetti attribuiti all’indebitamento 6) Rientro dall’indebitamento e sviluppo del sistema 7) Riflessioni conclusive
1) Introduzione
Negli ultimi tempi si va sottolineando da più parti la prospettiva di un allentamento delle politiche economiche rigoriste che da parecchi anni stanno imperversando nell’Europa dell’euro; difficile stabilirne la reale portata e la relativa valenza, ma indubbiamente qualcosa si sta muovendo in tal senso.
Sono stati infatti concessi ad alcuni Paesi maggiori dilazioni temporali per il riassorbimento del deficit di bilancio, mentre si va proponendo anche di considerare maggiori casi di esclusione dallo stesso degli investimenti, secondo una tecnica pur basilare e consolidata, anche a livello economico-aziendale, ora detta della golden rule.
Arduo, appunto, valutarne gli effetti sull’economia reale, anche se pare si possa fare un’affermazione di fondo, secondo la quale una sola, maggior dilazione dei termini per il c. d. “risanamento di bilancio”, senza un mutamento netto e sostanziale delle politiche economiche sin qui perseguite, avrebbe il solo effetto di posticipare l’agonia dei sistemi economici europei, ormai allo stremo, afflitti da una disoccupazione che supera i 25 milioni di individui, con pochi precedenti nella storia, senza minimamente incidere sulle cause di fondo che l’hanno determinata.
Tale affermazione richiede tuttavia una disamina delle relative cause, che paiono addirittura affondare le loro radici primigenie, al di là pertanto di fenomeni di tipo casuale ed esogeno, nella stessa concezione del fenomeno economico, riguardo alla sua essenza ed alle sue connotazioni, così come sono andate maturando nell’evoluzione del pensiero economico medesimo.
Senza dubbio, infatti, la crisi che coinvolge i paesi europei aderenti all’euro non può essere ricondotta ad una di tipo congiunturale; essa è invece connaturata in senso strutturale ad un modello di sviluppo evidentemente inadeguato; d’altra parte essa è riferibile, in termini così tragici, alla sola Europa, mentre altri sistemi economici hanno reagito o stanno reagendo ad una situazione nella quale la globalizzazione dei mercati di produzione pone indubbiamente dei problemi di competitività.
Non vi è accordo, tuttavia, sulle cause che hanno prodotto una devastazione così profonda e strutturale, mentre la relativa ricerca ed il loro acclaramento appare essenziale per tentare di porvi rimedio.
2) Effetti dell’introduzione dell’Euro
Pur in estrema sintesi, si può affermare che l’euro non è neppure una moneta nel senso tecnico dell’espressione. Ove lo fosse, essa necessiterebbe di un’unione anche politica, con una banca centrale che agisse da prestatore di ultima istanza, garantendo la necessità di assicurare almeno un medio circolante necessario e sufficiente all’attuazione di politiche economiche anche di sviluppo.
Così non è, e pertanto, benché stampato e circolante, esso possiede piuttosto i caratteri di una moneta soltanto virtuale, atta ad attuare un regime di cambi fissi all’interno di un’area di libero scambio. A fronte della creazione di tale moneta, i singoli Stati aderenti hanno tuttavia dovuto rinunciare a tutti gli strumenti di politica economica che hanno sempre rappresentato le tipiche modalità di intervento e di difesa di ciascun sistema, cioè la stessa creazione di base monetaria e le relative politiche, la regolazione del cambio, nonché l’utilizzo autonomo della politica fiscale e di bilancio.
Oltre alla cessione di sovranità conseguente, l’adozione dell’Euro ha rappresentato una mediazione
tra le monete forti dei paesi del Nord Europa e quelle più deboli di quelli del Sud: la risultante è stato un accrescimento netto di competitività dei primi a scapito dei secondi, con una conseguente distorsione dei flussi finanziari, indirizzatisi dai secondi verso i primi, che hanno accumulato omonime eccedenze, mentre in questi ultimi si sono formati disavanzi strutturali e non soltanto congiunturali. Si può infatti constatare che, non a caso, sono i Paesi dell’Europa del centro sud ad accusare le maggiori problematiche, che si vogliono invece spiegare esclusivamente con presunte carenze di competitività interna e di organizzazione sul piano amministrativo.
3) Le spinte deflazionistiche conseguenti agli accordi di Maastricht
Oltre a ciò, troppo spesso si trascura l’influenza degli accordi di Maastricht sull’odierna situazione, mentre le forti misure di rigore a questi riconducibili, particolarmente in tema di Patto di stabilità, hanno determinato, con la loro rigidità, una continua contrazione della spesa, anche degli enti territoriali, con particolare riferimento a quella per investimenti. Il risultato è stata una continua e lenta riduzione della correlativa domanda globale di ciascun paese aderente, che, dapprima inavvertita e perciò sottovalutata, ha in primo luogo determinato un blocco dello sviluppo e successivamente un precipitare verso stadi recessivi veri e propri dei relativi sistemi economici. Del resto ciò avrebbe dovuto ritenersi già scontato, a causa della logica perversa dell’effetto demoltiplicativo conseguente alla continua riduzione della domanda interna per consumi e investimenti.
Gli accordi di Maastricht, pertanto, si inquadrano in una logica che trascura del tutto l’influenza della domanda aggregata sull’equilibrio e sullo sviluppo dei sistemi economici, e la loro gravità sta appunto nell’aver ignorato principi che pur avrebbero dovuto ritenersi consolidati, alla luce delle dottrine economiche elaborate nel corso del XX secolo, oggetto anche di sperimentazione attraverso il superamento, grazie alle stesse, della crisi del ’29.
4) Il sovvertimento delle teorie economiche consolidate
Pare potersi a questo punto affermare che le cause sin qui sommariamente analizzate – il change over tra le monete nazionali e l’Euro, in assenza di adeguati correttivi, le carenze strutturali di quest’ultimo, nonché gli effetti deflazionistici conseguenti agli accordi di Maastricht – possano già ritenersi necessarie e sufficienti per spiegare la stato attuale delle economie europee; altre, più specifiche, come la crisi stessa del 2008, può aver solo concorso ad acclarare disfunzioni già strutturalmente esistenti, agendo con le stesse in maniera sinergica.
La gravità delle decisioni adottate a Maastricht non sta, tuttavia, soltanto nello specifico ambito di riferimento operativo, ma va inquadrata in un mutamento profondo della stessa concezione del funzionamento e dell’equilibrio dei sistemi economici.
Lo scopo dell’avvenuta fissazione di limitazioni al deficit di bilancio di ciascun Stato era da ricercarsi nel fatto – da ritenersi di per sé temporaneo - dell’inesistenza di un bilancio unico europeo, per cui ognuno di questi dovesse regolarsi in modo che lo stesso, ancorché non redatto effettivamente, presentasse comunque un deficit consolidato programmato. Tale procedura, ancorché condivisibile di per sé ove applicata in termini sostenibili, è stata tuttavia eccessivamente prolungata, ma soprattutto, imponendo limitazioni troppo anguste alle possibilità di sviluppo, ha significato una cosa ben più grave: l’affermazione, cioè, tradotta in misure di politica economica, che le domande globali dei sistemi economici non fossero da ritenersi rilevanti e che quindi si potessero, senza effetti rilevatisi poi devastanti, procedere a continue e massicce misure di contenimento delle stesse.
E’ questo il punto veramente cruciale, implicando una rottura con tutto il pensiero economico venutosi a creare praticamente nel corso del XX secolo, nel quale sono state le teorie keynesiane a porre l’accento sulla rilevanza proprio della domanda globale, accanto alla correlativa offerta, per l’equilibrio, inteso in termini dinamici, del sistema economico.
Domanda e offerta globali, infatti, costituiscono i due pilastri su quali si regge ogni economia; non può pertanto ignorarsi né l’una né l’altra, anche se la prima, in una situazione di forte progresso tecnico e di capacità produttiva inutilizzata, tende più che mai ad assumere una valenza fondamentale.
Tale non era, del resto, la tesi sostenuta dall’economia classica, con riferimento soprattutto alla fine del XIX secolo, che sottolineava, invece, la capacità dell’offerta nella creazione della propria domanda (legge di Say), rimarcando unicamente l’importanza della prima a fini di sviluppo.
Ciò può tuttavia ritenersi ammissibile con riferimento a mercati separati, che hanno costituito la metodologia di osservazione degli economisti classici, ma non a livello macroeconomico, per il quale la sovrapposizione dei ruoli tra i vari soggetti operanti nel sistema economico assegna alla domanda aggregata un ruolo preminente per lo sviluppo, così come, in senso opposto, per la formazione di spirali recessive.
Il disconoscimento del ruolo fondamentale della domanda all’interno del sistema economico, focalizzandosi, invece, prevalentemente sull’offerta, è stato recepito da un folto gruppo di economisti, che potrebbero pertanto definirsi esponenti di una “nuova economia classica”.
Il loro pensiero è accomunato da una mentalità che intende ispirarsi appunto a quella diffusa alla fine del XIX secolo, la quale, in assenza di una produzione industriale di massa, nonché di un settore terziario e di un welfare diffuso, poneva la propria focalizzazione prevalentemente sulle condizioni dell’offerta e sui relativi regimi di mercato.
Oggi non è più così: la produzione di massa, la terziarizzazione dell’economia, nonché la stessa esigenza di un accettabile welfare, rendono ogni sistema economico maggiormente interdipendente anche al suo interno e sempre meno assimilabile allo stereotipo di una lunga catena di montaggio nella quale il conseguimento di taluni risparmi di produzione rappresenta la leva per la creazione di un maggior benessere.
E’ vero invece il contrario: ogni risparmio realizzato, in termini occupazionali o di relativi costi, quasi rifacendosi ad una sorta di “controllo di gestione”, impone l’allocazione delle corrispondenti risorse in altri comparti del sistema, pena la caduta della domanda ed il concretizzarsi di tensioni deflazionistiche; coloro che sostengono il contrario sono gli adepti di una mentalità mercantilista, che tende sempre più a considerare il sistema economico secondo una logica di tipo aziendalistico, nel quale sono essenziali le sole leggi dell’offerta, puntando su una domanda esogena al sistema. La loro visione è perdente, come lo sono già state quelle analoghe nel corso della storia, anche se, nell’odierna fase di globalizzazione, si tende a riproporre indubbiamente l’assimilazione di ciascun sistema economico, a fronte di quello globalizzato, alla stregua di uno derivato, quali sono sempre state le aziende nei confronti del proprio.
Ne deriva una visione essenzialmente tecnocratica, in spregio all’economia intesa come scambio, la quale ultima tende tuttavia, per legge naturale, comunque a riproporsi, non appena ci si accorga che le politiche mercantiliste medesime tendono ad annullarsi da sole, in termini di reciprocità, ponendo nuovamente la necessità di riformulare le condizioni di equilibrio attraverso il ripristino di un livello fisiologico della domanda interna.
Quest’ultima assume pertanto, nei sistemi economici evoluti, un ruolo essenziale, sempre da salvaguardare, perché è essa stessa a determinare – se si eccettuano le problematiche di lungo termine relative alla disponibilità delle fonti energetiche – la convenienza a produrre in vista di un fisiologico scambio di beni e servizi.
Come già accennato, invece, le politiche attuate negli ultimi decenni in Europa sono sempre state improntate a tagliare la domanda medesima, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti.
Non dovrebbe invece mai neppure pensarsi, in una fase recessiva, ad una contrazione della spesa pubblica, specialmente attraverso tagli unicamente lineari, togliendo ulteriore potere di acquisto dal sistema quando questo ne avrebbe assoluto bisogno; sarebbe, invece, sempre opportuno un ridimensionamento di quella improduttiva, ma riconvertendola, per volumi almeno invariati, in una maggiormente produttiva, preferibilmente per investimenti.
Si raccomanda, invece, da più parti, una contrazione della spesa pubblica medesima, coniugata ad una correlativa dell’imposizione fiscale.
E’appena il caso di notare che a ciò corrispondono effetti depressivi netti per la domanda aggregata: tra i due moltiplicatori, infatti, quello negativo conseguente alla minor spesa pubblica prevale come valenza su quello positivo, riconducibile al maggior reddito disponibile, nel caso di un bilancio statale con prevalenza di imposte dirette (teorema del bilancio equilibrato o di Haavelmo, riferito a manovre deflazionistiche).
Una minor spesa pubblica, pertanto, quantunque coniugata a riduzioni di imposta, esercita sul sistema economico, nel caso di prevalenza di imposizione diretta, un effetto netto deflazionistico sulla domanda globale.
5) Gli effetti attribuiti all’indebitamento
Tra le cause alle quali sarebbe riconducibile la situazione di crisi strutturale in cui è precipitato particolarmente il nostro Paese viene prevalentemente annoverato l’alto livello di indebitamento pubblico, adducendo anche, a conforto di tale assunto, le pubblicazioni di Reihart-Rogoff, secondo le quali uno Stato che abbia un rapporto debito/pil superiore al 90 per cento vedrebbe compromesse le proprie possibilità di crescita.
Mentre tale tesi è stata di recente severamente criticata come non veritiera, già in via deduttiva si può sostenere che il livello del debito pubblico, di per sé, non ha in generale quella valenza così drastica per la crescita di un sistema economico che ad esso si intende invece riconnettere: ciò perché gli interessi sullo stesso, ove classato presso soggetti residenti, attuano una compensazione, in termini aggregati, col carico tributario, rappresentando soltanto una partita di giro (principio di Ricardo); essi determinano pertanto un carico tributario effettivo diverso da quello conseguente alle aliquote nominali d’imposta, ma, proprio per questa loro valenza in termini soltanto differenziali, non possono costituire, di per sé, un ostacolo diretto per lo sviluppo del sistema economico.
A maggiori interessi corrisposti sul debito pubblico corrisponde certamente un più alto livello di tassazione, ma, pur a fronte di un effetto redistributivo del carico tributario medesimo, è soltanto quello netto a determinare la dinamica del sistema, influenzando per pari importo la domanda globale.
E’ ben vero, tuttavia, che la maggior pressione esercitata sui mercati finanziari tende, in tal caso, a determinare un livello mediamente più alto dei tassi di interesse, creando un effetto di spiazzamento (crowding out) a favore dello Stato, ma è lecito ammettere che, in una situazione di globalizzazione dei mercati, tale livello possa ritenersi soltanto parziale, o comunque da valutarsi unitamente alle altre variabili economiche.
Un alto livello di indebitamento pubblico può comportare, invece, rischi di altro genere, comuni a qualsiasi debitore che debba rinnovare i propri debiti: esso si espone indubbiamente ad un rischio di dipendenza dai mercati, dovendo comunque accettare il livello dei tassi di interesse correnti al momento del rinnovo dei propri debiti, così come può incorrere in possibili pressioni speculative dei mercati medesimi ed anche in manovre a danno dei propri titoli, siano esse motivate o non.
Un grande debito pubblico, pertanto, determina certamente un rischio in tal senso, tuttavia tanto minore quanto più esso è detenuto da soggetti residenti, ma non può costituire, per quanto detto, un ostacolo che possa seriamente ledere le possibilità di sviluppo del sistema economico.
Al contrario, invece, un paese fortemente indebitato non può assolutamente permettersi il lusso di non crescere, perché potrebbe ingenerare nei mercati una sensazione di rischio maggiore di altri; perciò l’Europa, dopo avere imposto politiche contrarie alla crescita, non dovrebbe incolpare di ciò quei Paesi che siano incorsi in situazioni di rischio a ciò conseguenti, negando, in termini minimali, un eventuale sostegno automatico e senza condizioni, in situazioni chiaramente speculative, alle quotazioni dei titoli del debito pubblico degli Stati aderenti.
6) Rientro dall’indebitamento e sviluppo del sistema
Se gli effetti di un pur cospicuo debito pubblico, soprattutto se detenuto in gran parte da soggetti residenti, non esplica quegli effetti così disastrosi sul sistema economico che molti continuano a ritenere, le manovre di rientro da tale indebitamento possono, esse sì, risultare veramente micidiali; e ciò per quanto già affermato a proposito delle condizioni di equilibrio macroeconomico del sistema, che non può tollerare una deflazione della domanda superiore a certi limiti di sostenibilità, conseguente agli alti livelli di tassazione a ciò necessari.
Anche qui, sono i nuovi economisti classici a sostenere che il risanamento delle finanze pubbliche debba precedere ogni sostenibile sviluppo. In realtà, tale risanamento, ove inteso in termini di riduzione dell’indebitamento accumulato, si pone in assoluta dicotomia con lo sviluppo medesimo, lasciando andare il sistema sempre più in recessione; ciò a meno che non si innesti in un ciclo di sviluppo consolidato, nel quale si possono invece utilizzare le maggiori risorse emergenti per una seria politica di rientro sostenibile dall’indebitamento medesimo, perseguendo nel contempo effetti perequativi dello stesso andamento ciclico.
In tale ultimo quadro il rapporto debito/pil potrebbe effettivamente segnare una riduzione, sia per l’accrescimento, in termini reali, del denominatore, sia per quello dovuto ad un livello inflazionistico comunque controllato che diverrebbe sinergico all’obiettivo posto.
Del resto, al di là di manovre straordinarie per la riduzione dell’indebitamento pubblico, spesso attuate nella storia, e che si sperava di non rivedere più, pare non si sia mai neppure posta la soluzione di ridurlo gradualmente, in dosi massicce, proprio per il conflitto estremo che si viene a porre tra tale modalità e le possibilità di sviluppo del sistema.
Pone pertanto serie perplessità l’avvenuta accettazione, da parte del nostro Paese, della condizione di ridurre, in un ventennio, l’eccedenza rispetto al 60 per cento del Pil, in base al fiscal compact, così come si evidenzia il persistere, soprattutto a livello europeo, di quella mentalità totalizzante, ispirata alla nuova economia classica, che continua, pur a fronte della grave situazione creata, a ribadire la sostanziale irrilevanza della domanda per l’equilibrio e lo sviluppo dei sistemi economici.
La destinazione di risorse alla riduzione dell’indebitamento crea infatti una diffusa deflazione, a causa dell’eccessivo carico tributario che richiede, riducendo il reddito disponibile e deprimendo in tal modo consumi e investimenti.
La risultante – tenuto conto anche dell’entità della manovra tributaria a ciò specificatamente necessaria, pari ad oltre 50 miliardi annui per un ventennio – non potrà che essere un immane processo demoltiplicativo della domanda che porterà ineluttabilmente il sistema verso una condizione di diffusa povertà.
Né si può addurre alcun presunto effetto benefico conseguente alla riduzione del peso degli interessi, inteso quale risanamento, per il futuro di un sistema per il quale non sarebbe neppure configurabile alcuna possibilità di competitività e di ripresa.
Ma, al di là dell’accettazione del fiscal compact, emergono anche nella legislazione interna taluni punti che evidenziano il persistere di tale mentalità convenzionale, evidenziando un pari favor verso la riduzione dell’indebitamento, piuttosto che indirizzarsi, in luogo di ciò, verso l’investimento e la produzione.
Anche nella legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del principio costituzionale del pareggio di bilancio – sul quale non si esprime qui alcuna valutazione – talune disposizioni si pongono nella stessa ottica: in particolare l’art. 9, comma 3, in tema di equilibri di bilancio degli enti territoriali, ove si afferma espressamente che gli eventuali saldi positivi emergenti sono appunto destinati alla riduzione dell’indebitamento e solo subordinatamente, nel rispetto dei vincoli previsti, al finanziamento di spese di investimento.
Del resto, l’art. 8, comma 1, legge 12 novembre 2011, n. 183, già prevedeva che gli enti locali dovessero ridurre lo stock del debito eccedente quello pro-capite stabilito in un apposito decreto emanando, secondo modalità fissate dallo stesso; a tutt’oggi la norma non è operativa, in assenza di tale decreto applicativo, ma resta comunque la constatazione di fondo di una filosofia sempre alternativa allo sviluppo, mentre anche le disposizioni fissate nella citata legge n. 243/2012 possono porre seri problemi, anche alla finanza locale, riducendo ulteriormente la capacità di indurre una qualche possibilità di sviluppo.
7) Riflessioni conclusive
L’assunto qui sostenuto relativamente alle cause dell’odierna recessione negli Stati europei aderenti all’Euro, non a caso particolarmente grave in quelli del centro-sud, giunge ad identificarne solo alcune, ritenendole beninteso non le uniche, ma comunque quelle con maggior valenza di fondo.
Il change over tra le monete nazionali e l’euro, penalizzante proprio per i paesi ora maggiormente in crisi, ne costituisce una certamente rilevante e di carattere strutturale; accanto a questa, si pone la mancata realizzazione dell’euro come moneta vera e propria, in grado di stimolare lo sviluppo e l’aggregazione dei sistemi economici, piuttosto che attuare politiche praticamente solo deflazionistiche. Ma è certamente la nuova cultura economica che porta a disconoscere ogni importanza al secondo pilastro di ogni sistema economico – la domanda – a rappresentare emblematicamente una filosofia regressiva verso stadi del pensiero economico che si credevano ormai superati.
Pertanto, se si è inizialmente posto in risalto un allentamento possibile delle politiche economiche improntate al rigore, ciò può rappresentare ben poca cosa ove non si cambi radicalmente l’approccio, constatando come le tesi sostenute dalla nuova economia classica, con la loro puntuale attuazione nelle politiche medesime, abbiano portato l’Europa sull’orlo di un baratro.
Si sono invece disconosciute le teorie keynesiane, che hanno significativamente trovato spazio nel XX secolo, pur a fronte del successo che la Storia ha loro tributato per l’uscita dalla crisi del’29 e per lo sviluppo post-bellico. A nulla possono valere, infatti, gli indubbi eccessi nel loro utilizzo, sul finire del secolo stesso, frutto di politiche che hanno travalicato dalla loro corretta applicazione, determinando eccessi sulle finanze pubbliche e situazioni inflazionistiche.
Ciò avrebbe dovuto caso mai promuovere una sintesi nell’evoluzione del pensiero economico, introducendo principi atti a determinare uno sviluppo sostenibile, in termini di finanza funzionale controllata, soprattutto attraverso misure anticicliche basate proprio sulla regolazione della domanda, nelle quali avrebbe potuto innestarsi, nelle fasi espansive dell’economia, una politica di controllo e di riduzione dell’indebitamento precedentemente contratto.
La rottura totale che si è invece creata ha riportato indietro l’orizzonte del pensiero economico, focalizzandolo verso modelli ancestrali, solo astrattamente riproponibili, pur col loro fardello di dogmi e di limiti, già abbondantemente evidenziati nel corso della storia.
Da qui l’immaginare che il fenomeno economico consista, in ogni caso, soltanto nella ricerca del costo di produzione che minimizzi comunque l’utilizzo delle risorse, come pur validamente sostenuto, a livello microeconomico, proprio dagli economisti classici; principio che se è comunque applicabile a tale ambito, viene tuttavia a mutare di valenza a livello macroeconomico, laddove l’utilizzo di tali risorse interagisce con la stessa possibilità di collocare la produzione attuata.
Immaginando l’intero sistema economico appunto come una sorta di catena produttiva, da razionalizzare soltanto, minimizzandone i costi, si dimentica che gli addetti rappresentano, invece, al tempo stesso, anche i destinatari finali: ecco la scomparsa, pertanto, di uno dei due pilastri fondamentali, appunto la capacità di spesa di questi, parte della domanda globale del sistema.
Si spiegano così le politiche deflazionistiche predisposte a Maastricht, l’irrilevanza sostanziale per le manchevolezze tecniche dell’euro, nonché la stessa concezione vincolistica al pareggio in tema di bilanci pubblici, anche per le spese di investimento, attuata nel nostro Paese con modifiche addirittura costituzionali, pur in assenza di adeguate garanzie sostitutive, delegate all’Unione europea, per le necessarie politiche di indebitamento e di sviluppo, e che pertanto rischia di rappresentare un’ulteriore cessione di sovranità senza sicure contropartite.
Tuttavia, la filosofia di fondo, emergente non solo dal fiscal compact, ma diffusa anche nella legislazione interna, che antepone, in linea generale, la riduzione del debito in essere piuttosto che destinare le relative risorse alla produzione ed all’investimento, assume una particolare gravità.
Essa non è infatti riferita a situazioni singole, nelle quali potrebbe ben risultare comparativamente conveniente un rimborso anticipato di un debito contratto, ma lo fa in modo astratto, prescindendo da ogni valutazione del caso concreto.
Sottrarre risorse, in linea generale, alla produzione ed all’investimento, credendo di poterle così alternativamente destinare, significa infatti snaturare il fine stesso dell’attività economica nella sua essenza di base, negando veramente, in tal modo, un futuro per le successive generazioni.
Riguardo alle disposizioni riferibili in proposito agli enti territoriali, già accennate, la riduzione anticipata dell’indebitamento, al di là dei piani di ammortamento predisposti, riportandolo al di sotto di determinati parametri, determinerebbe un aumento dell’imposizione fiscale locale, facendo affluire fondi, prima delle relative scadenze, direttamente agli enti creditizi e finanziari mutuanti.
Nel caso dello Stato, poi, i fondi affluiti con l’imposizione fiscale centrale potrebbero essere utilizzati per consentire lo smobilizzo dei titoli pubblici classati anche presso lo stesso sistema creditizio, procedendo quindi al loro annullamento.
Tali operazioni, tuttavia, mentre rappresenterebbero un vantaggio immediato per quest’ultimo, risulterebbero, al solito, particolarmente nella situazione attuale dell’economia, ma anche per il loro ammontare certamente cospicuo, oltremodo deflazionistiche sulla domanda globale, penalizzando, nel contempo, lo stesso sistema creditizio, sì da non consentire ad esso di fornire, in un quadro fisiologico e con rischi preventivabili, i fondi necessari alle imprese, proprio per la recessione ancora più profonda che si sarebbe venuta a creare.
Vasto e profondo appare pertanto il cambiamento necessario, prima nella mentalità dell’approccio e successivamente nelle modalità operative, onde evitare che i sistemi economici europei si avvitino ancor più in spirali recessive senza ritorno, per il cui fronteggiamento, in assenza di parametri economici compatibili con uno sviluppo sostenibile, a nulla varrebbero le c. d. “riforme”, da più parti auspicate, ma che, rischiando di non cogliere l’essenza della problematica, risulterebbero quanto meno inutili, pur potendo anche, come spesso accade di fronte alla necessità dell’agire urgente, risultare deleterie e oltremodo penalizzanti.
Giugno 2013 Francesco Strocchia
04/06/2013
Documento n.9414